Le Dinamiche del Collezionismo | Aprile 2025
Le opere d’arte sono oggetti dal valore complesso e, questa duplice natura, crea di fatto una serie di tensioni tra la necessità di proteggere il patrimonio collettivo e la libertà del mercato.
Come Ceresio Investors abbiamo avuto recentemente il piacere di ospitare un dialogo tra professionisti in cui sono state affrontate le implicazioni che la detenzione di una Collezione o di un'opera d'arte comporta.
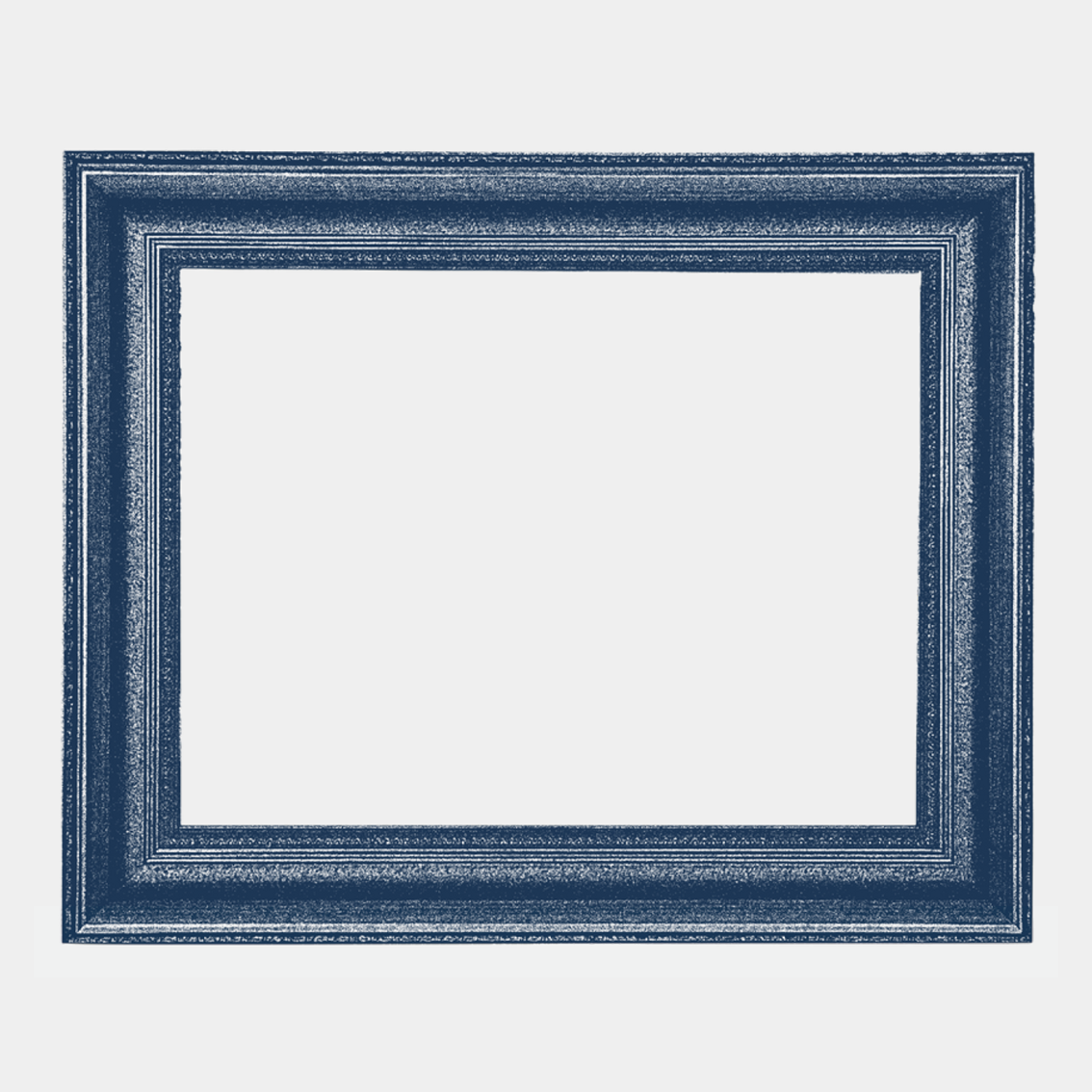
Le Limitazioni del Diritto di Proprietà di un’Opera d’Arte
Giuseppe Calabi - Avvocato
Il diritto di proprietà di un’opera d’arte non è assoluto. Esistono interventi normativi e regolatori che ne limitano la gestione e la commercializzazione. Un esempio significativo è il “diritto di seguito”, che garantisce agli artisti o ai loro eredi una percentuale sulle vendite delle loro opere successive alla prima. Un altro vincolo rilevante riguarda la cd. notifica, che rappresenta l’atto con il quale il Ministero della Cultura notifica appunto al proprietario la dichiarazione dell’interesse culturale di un bene.
Questa circostanza può sorgere in tre occasioni tipiche:
- al momento dell’esportazione di un’opera,
- al momento della vendita di un’opera in asta,
- al momento dell’esposizione di un’opera.
L’opera appartenente al privato può conseguire lo status di bene culturale solo in forza di un provvedimento amministrativo che accerti, in capo ad essa, la sussistenza di un interesse storico-artistico particolarmente importante.
La notifica, sebbene avvalori lo status dell’opera, non è necessariamente gradita al collezionista italiano in quanto spesso comporta una drastica riduzione del valore dell’opera (si stima fino a due terzi) e, a differenza di altri paesi come la Francia, in Italia questa perdita non viene compensata da indennizzi statali. Inoltre, la notifica può essere molto pervasiva quando riguarda una collezione come “universalità” di oggetti. In questo caso il Ministero vuole evitare ciò che, con un linguaggio un po' plastico, il legislatore definisce smembramento, e quindi vuole mantenere integra la collezione affinché non venga dispersa.
Un ulteriore e ancora più gravoso vincolo che può essere impresso dalla notifica avviene quando la collezione è vincolata in modo pertinenziale a un immobile che la contiene. Il sistema della notifica è un caso prevalentemente italiano e, sebbene esistano esemplari sistemi di tutela in altri ordinamenti, generalmente il diritto di proprietà è maggiormente rispettato in altri Paesi. Ad esempio in Francia si utilizza il termine giuridico di “servitù pubblica”, a fronte del quale è previsto un indennizzo per il privato possessore del bene soggetto a notifica.
Rispetto all'esportazione inoltre, un diniego di esportazione in Francia è di fatto solo temporaneo e serve a permettere allo Stato di raccogliere i fondi sufficienti per poter fare un'offerta di acquisto ai valori di mercato internazionale.
La Funzione degli Archivi d’Artista Oggi
Valentina Sonzogni - Direttrice Archivio Piero Dorazio
Gli archivi d’artista svolgono un ruolo fondamentale nella conservazione e valorizzazione
delle opere. La loro missione si può articolare in tre funzioni chiave:
- Preservare: raccogliendo e ordinando tutto ciò che può testimoniare la vita e l’opera dell’artista.
- Promuovere: diffondendo la conoscenza delle opere, non solo tra studiosi e istituti accreditati, ma anche attraverso progetti divulgativi aperti al pubblico e alle nuove generazioni di ricercatori.
- Proteggere: difendendo l’autenticità delle opere. In questo senso, sebbene le nuove tecnologie rendano sempre più semplice la creazione di falsi, falsificare la provenienza e la storia documentata di un’opera resta estremamente difficile e gli archivi, grazie alla conoscenza ai documenti conservati, rappresentano una preziosa difesa.
Nonostante la chiara missione dell’archivio, nel mondo esiste una grossa differenza di
culturale e di approccio tra archivi.
In generale i collezionisti quando si rivolgono ad un archivio tendono a sentirsi sotto indagine
(quasi come se l’archivio stesse facendo una valutazione sul proprietario più ancora che
sull'opera) e si crea una certa forma di ansia nel collezionista in quanto la voce dell'archivio è
una voce fondamentale per potersi rivolgere a una casa d'aste italiana o internazionale per
acquistare o vendere un quadro. Questo ha evidentemente creato una grossa discussione sul ruolo e sulla responsabilità degli archivi. Alcuni detrattori degli archivi sostengono addirittura che gli archivi siano titolari di fatto di una cultura quasi monopolistica.
Certo è che non esistono e non dovrebbero esistere delle leggi che sottopongano il lavoro
degli archivi a un controllo pubblico, cosa che sarebbe peraltro dannosa per il mercato e
per il sistema dell’arte in generale.
In Italia e Francia, la legge tutela la libertà di opinione degli archivi, stabilendo che non
possono essere costretti a esprimere giudizi sull’autenticità di un’opera, e che la loro
valutazione è protetta dalla libertà di espressione. Non si può dunque obbligare un archivio a esprimere un'opinione o esprimersi sull'autenticità o meno di un'opera. Non esiste un diritto assoluto all'autenticità, se ci si rivolge ad un archivio è necessario mettere in conto che l'archivio ha la facoltà di esprimersi in modo negativo oppure di non esprimersi, o ancora di richiedere tempo.
In America la situazione è molto diversa perché il potere monopolistico degli archivi è stato
pesantemente attaccato addirittura con cause in cui è stata invocate la legislazione antitrust
e molti archivi hanno chiuso gli authentication boards, quindi non autenticano più, in un
modo certamente un po’ ambiguo per risolvere la questione.
Le Tematiche Fiscali nella Detenzione di Opere d’Arte
Mirko Orsi - Responsabile Wealth Planning, Ceresio Investors
Il nuovo testo unico in materia di imposte sui redditi, il d.p.R. 22/12/1986, n. 917, nel sostituire il precedente Tuir, il d.p.R. 29/09/1973, n. 597, non reca più la disposizione normativa che disciplinava gli atti dispositivi a contenuto speculativo aventi ad oggetto le opere d’arte.
La vecchia disposizione (quindi non riproposta nell’attuale Tuir) fissava una presunzione assoluta di legge, secondo cui se l’opera d’arte era alienata entro due anni dall’acquisto, presunto in via assoluta l’intento speculativo del collezionista, la plusvalenza realizzata risultava fiscalmente rilevante, e quindi da assoggettare a tassazione.
Il fatto che la vecchia disposizione non sia stata trasposta nell’attuale Tuir autorizzerebbe a supporre che il legislatore abbia deciso di non assoggettare a tassazione i fenomeni connessi alla dinamica di aggiornamento delle collezioni d’arte, caratterizzate da una naturale propensione alla compravendita. Tuttavia, l’assenza di una specifica previsione normativa non deve indurre a ritenere che tutti i fenomeni connessi alla compravendita di opere d’arte si collochino al di fuori di qualsiasi sindacato da parte dell’Amministrazione Finanziaria in tema di qualificazione e determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.
Se da un lato è agevole inquadrare dal punto di vista tributario l’attività del mercante d’arte, che per definizione risulta essere un imprenditore cui associare un reddito d’impresa, dall’altro i restanti fenomeni di compravendita di opere d’arte sono lasciati all’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria in sede di verifica fiscale. Sono sempre più frequenti, infatti, i casi per i quali l'Amministrazione Finanziaria, seppur, come si diceva, in assenza di una norma di riferimento, ha interpretato la compravendita di opere d’arte come un’attività d’impresa esercitata occasionalmente, con la conseguenza di ricomprendere nella categoria dei redditi diversi il risultato positivo conseguito.
Tale approccio interpretativo dell’Amministrazione Finanziaria ha recentemente trovato terreno fertile in una serie di arresti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, secondo cui coloro che operano nel mercato dell’arte trovano riscontro in una delle tre seguenti tassonomie:
- Il mercante d’arte, che, come si è detto, risulta essere un imprenditore connotato del segno distintivo della professionalità e che, come tale, risulta essere produttore di reddito d’impresa;
- L’operatore in relazione al quale non è possibile riscontrare i segni distintivi del mercante d’arte, ma che, tuttavia, opera nel settore manifestando chiari segni speculativi, e che pertanto risulta inquadrabile fra coloro che esercitano una attività d’impresa, benché con modalità occasionali;
- L’operatore, infine, che si comporta da vero e proprio collezionista d’arte, ossia colui il quale intende di volta in volta aggiornare la propria collezione d’arte al mero scopo di incrementarne il valore culturale, nonché la capacità di assicurare un godimento morale per colui che la possiede (cd. “passion dividend”).
Trattando invece dei passaggi generazionali di ricchezza, e segnatamente quelli mortis causa, è meritevole di attenzione la disposizione del TUS (testo unico in materia di imposta di successione e donazione) in base alla quale il valore delle opere d’arte comprese nell’attivo ereditario è determinato in maniera forfetaria pari al 10% del valore dell’attivo ereditario.
Le opere d’arte sono considerate parte della mobilia posta ad ornamento delle abitazioni, e ciò consente di estendere ad esse il criterio di forfetizzazione previsto per il denaro, i gioielli e, appunto, la mobilia. Tale criterio di forfetizzazione, tuttavia, risulta applicabile nella sola ipotesi in cui le opere d’arte risultano contenute nell’abitazione del de cuius alla data di apertura della successione, risultando quindi non applicabile ai casi in cui le opere d’arte sono custodite, per esigenze di sicurezza e conservazione in un caveau, o comunque collocate al di fuori dell’abitazione per esigenze espositive.
La Fiduciaria come Strumento per i Collezionisti
Paolo Daminelli - Direttore Generale, Eurofinleading Fiduciaria
L’attività fiduciaria è abitualmente associata alle partecipazioni societarie oppure agli investimenti di natura finanziaria. In realtà la legge istitutiva n. 1966/39 identifica le società fiduciarie nelle imprese che si propongono di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, senza specifica né della natura dei beni, né della modalità di realizzazione dell’amministrazione stessa.
In linea teorica, pertanto, le società fiduciarie possono intervenire anche nell’amministrazione di opere o collezioni d’arta. La stessa amministrazione finanziaria, nel definire le modalità di rimpatrio dei capitali posseduti all’estero, tra i quali le opere d’arte, annoverava la possibilità di affidarne l’amministrazione ad un intermediario abilitato, categoria alla quale appartengono proprio le società fiduciarie.
Abitualmente le motivazioni del ricorso all’attività fiduciaria rientrano in tre principali scopi del rapporto, che valgono anche per l’amministrazione di una collezione d’arte.
- Riservatezza: è la ragione storica che giustifica l’istituzione delle società fiduciarie. La società fiduciaria può intervenire nella compravendita di un’opera d’arte o di una collezione, sia tra privati sia per il tramite di case d’aste, garantendo così l’anonimato del collezionista nelle fasi di trattativa e/o di esecuzione. Nel rispetto della vigente normativa, ovviamente, la società fiduciaria dovrà ricevere in via preventiva tutte le istruzioni in modo puntuale e la dotazione dei mezzi finanziari necessari all’esecuzione dell’incarico.
- Garanzia nelle transazioni: la fiduciaria può fungere da garante in operazioni articolate, dando esecuzione alla consegna ovvero ai pagamenti al verificarsi delle condizioni legali e contrattuali, quale la rinuncia alla prelazione da parte della soprintendenza.
- Semplificazione degli oneri dichiarativi: si tratta forse del ruolo più recente, nato proprio in occasione degli scudi fiscali come sopra accennato. La forma contrattuale utilizzata è quella del mandato di amministrazione senza intestazione, che consente di mantenere le opere d’arte nella disponibilità del collezionista ovvero in un deposito, a condizione che la fiduciaria sia messa nelle condizioni di amministrarle
Conclusioni
Le opere d’arte sono molto più di semplici oggetti di bellezza: esse incarnano valori culturaliprofondi e, al contempo, rappresentano beni economici di grande rilevanza. Questadoppia natura richiede un approccio equilibrato, che sappia conciliare la tutela delpatrimonio culturale con le dinamiche del mercato.Le limitazioni giuridiche, la funzione degli archivi, le questioni fiscali e gli strumenti digestione patrimoniale sono tutti elementi che contribuiscono a determinare la gestione piùcorretta di un’opera d’arte.
Comprendere queste dinamiche è essenziale per chiunquedesideri avvicinarsi al mondo dell’arte con consapevolezza e responsabilità.In definitiva, la vera sfida è quella di trovare un equilibrio tra la salvaguardia della cultura ela valorizzazione economica delle opere d’arte, affinché esse possano continuare a ispiraree arricchire le generazioni future.